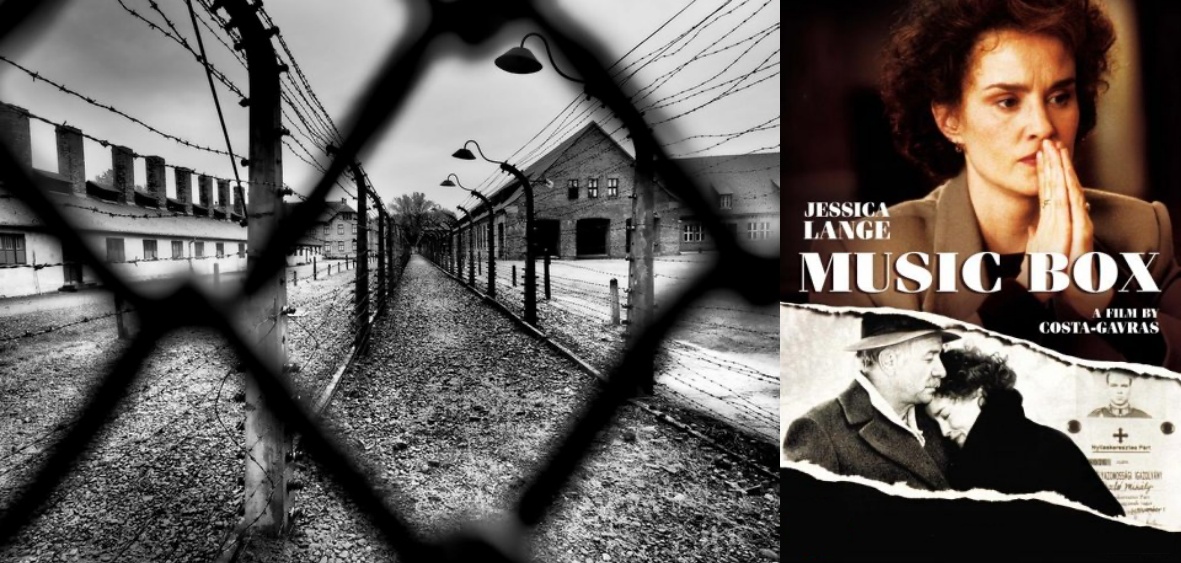
Si avvicina il Giorno della memoria e con questo il susseguirsi di dichiarazioni che se da una parte evocano il senso di una ritualità necessaria e collaudata negli anni, dall’altra lanciano un doppio allarme: il rischio di cadere in una retorica reiterata che interessa sempre meno e la forte preoccupazione che con la drammatica diminuzione del numero dei testimoni sopravvissuti, ormai in età particolarmente avanzata, si perdi nel tempo quella forza comunicativa in grado di trasmettere memoria e consapevolezza e in grado, tra l’altro, di contrastare il sempre presente virus del negazionismo.
Rischi in grado di riverberarsi sui preziosi insegnamenti che è possibile trarre dalla celebrazione della Giornata della memoria in quanto occasione per riflettere sulla natura dell’essere umano lì dove si viene portati a considerare, non solo di cosa sia stato capace l’uomo nel pieno della più alta espressione della civiltà moderna, ma anche di come si sia potuto risorgere dagli abissi dell’inferno (v. Sonnino, “Trauma della Shoah, ebraismo e psicoanalisi”, 2021).
Ma quali soluzioni pensare per il prossimo futuro quando anche l’ultimo dei testimoni non potrà più svolgere la sua preziosa opera?
Credo che la risposta a questo importante interrogativo stia nel coinvolgimento dei figli e dei nipoti dei carnefici, spesso anch’essi oggetto di vissuto traumatico nel momento in cui dovessero imbattersi in una verità storica non sempre narrata apertamente nei racconti condivisi nelle proprie famiglie (v. Schwarz, “I senza memoria”, 2019).
La loro testimonianza, lì dove dovesse basarsi sul riconoscimento consapevole delle responsabilità dei propri ascendenti, oltre a consentire l’inizio dell’elaborazione di un vero e proprio vissuto traumatico, come la psicoanalisi insegna, potrebbe rappresentare l’antidoto più efficacie contro il rischio di un oblio collettivo, rischio recentemente denunciato anche da Liliana Segre, e contrastare efficacemente quelle voci negazioniste mai stanche di farsi sentire e di reclutare consensi.















