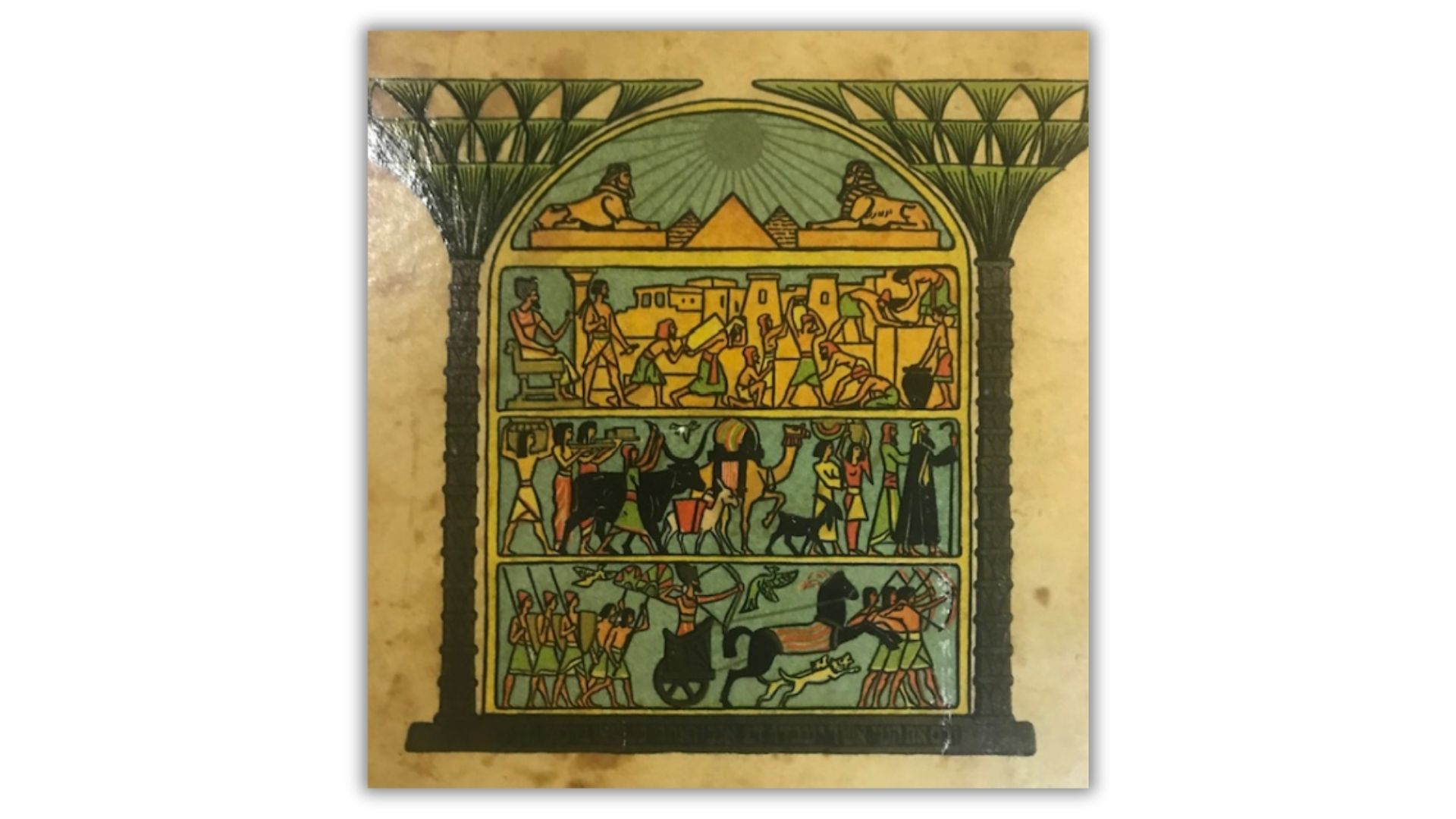Pubblichiamo di seguito l’intervento integrale del Rabbino Capo di Roma Rav Riccardo Di Segni, nell’ambito dell’incontro “Pellegrini di speranza” alla Pontificia Università Lateranense, in occasione della trentaseiesima Giornata per il dialogo tra cattolici ed ebrei.
Come è noto, l’argomento di questo incontro annuale è deciso concordemente dalla Conferenza Episcopale Italiana (CEI) e all’Assemblea Rabbinica Italiana (ARI). Quest’anno, essendo per la chiesa cattolica anno giubilare, abbiamo pensato che potesse essere interessante un confronto su questo tema di origini bibliche. Ma al tempo stesso stiamo vivendo tempi molto difficili che impattano tra l’altro sul dialogo ebraico-cristiano e una riflessione su questo punto non può essere elusa, cominciando proprio con un colloquio tra amici, che è quello che si svolge qui oggi. Per cui il mio intervento parlerà prima un po’ del Giubileo, e poi del momento difficile che stiamo attraversando.
Sul Giubileo, istituto di fondazione biblica, potrete trovare ampie spiegazioni nei sussidi che abbiamo contribuito a preparare. In questa sede vorrei parlare di un dettaglio e di una discussione intorno al Giubileo che è molto interessante nel delineare i confini tra le due fedi. Un paio di settimane fa, c’è stata nei social della nostra comunità, una piccola ma accesa discussione, che è sfuggita al vasto pubblico. Come sapete il tono dei social non è esattamente quello dei dibattiti sottili e raffinati. Comunque, il tema in discussione era interessante. Era appena successo che si erano svolte in varie città le cerimonie di apertura della porta santa e le clip circolavano per i media. In alcuni di questi si vedeva che prima che il vescovo bussasse alla porta e dicesse “aprite per me le porte della giustizia”, che qualcuno suonava lo shofàr, il corno di ariete. In questo c’era un preciso riferimento biblico, perché è la Bibbia a prescrivere che l’inizio del giubileo sia solennemente annunciato dal suono dello shofar in tutta la terra durante il giorno di Kippur. Giubileo deriva da Jovèl che a sua volta significa “montone” o “corno di montone”. Perché i social ebraici si agitavano? Perché lo shofàr per gli ebrei ha una grande importanza, è al centro della liturgia del capodanno, e il suo suono fa vibrare le coscienze. Quando mi è stato chiesto che significa lo shofàr per gli ebrei ho spiegato che sta agli ebrei come le campane stanno ai cristiani. Ricordate Pier Capponi, “voi sonerete le vostre trombe noi suoneremo le nostre campane”; anche se in quel caso l’accezione era militare, è un segno dell’importanza culturale di quel suono che caratterizza la civiltà cristiana che allo shofàr ha rinunciato. Ora la ripresa di questo strumento è parsa a qualcuno della nostra comunità l’appropriazione di una nostra cosa sacra, e qualcuno ha parlato anche di sostituzionismo.
Sono intervenuto con due righe in questo dibattito segnalando una contraddizione e un problema. Proprio tre settimane prima c’era stata un’altra storia, questa molto più diffusa mediaticamente. Quando il papa si era fatto fotografare in preghiera davanti a un presepe in sala Nervi nel quale il bambinello, messo là prematuramente, era appoggiato su una kefia palestinese. La cosa aveva sollevato da una parte molti consensi, e dalla nostra parte molte proteste, per due motivi; il primo politico, perché si trattava di una scelta di campo ben precisa propal, e il secondo, a mio avviso più grave, di carattere religioso, perché si spogliava Gesù e il cristianesimo delle sue radici ebraiche e lo si trasformava in qualcos’altro. Rispetto a queste proteste che condividevo ho fatto notare che da una parte noi protestiamo se si degiudaizza il cristianesimo e dall’altra se si giudaizza, come si fa suonando lo shofàr, si protesta. Qui si tratta di definire, sia per la nostra sensibilità, ma soprattutto per la sensibilità cristiana, quali siano i confini tra le due fedi. Il problema si pone ad esempio da circa mezzo secolo ogni anno a Pasqua, quando il giovedì santo gruppi di fedeli cristiani si riuniscono per evocare l’ultima cena recitando la haggadà di Pesach con i pasti rituali del seder. Ho visto alcuni di questi testi, in cui c’è una prima parte di copia-incolla del rito del seder e poi l’annuncio cristiano. Un mix che suona molto strano a un ebreo ma che non ha mancato di sollevare richiami anche da parte di autorità cattoliche, peraltro moderate, che non considerano lecita un’eccessiva giudaizzazione. Il problema è quello di trovare un giusto equilibrio. E non è semplice. Ma è attuale, perché il momento che viviamo è quello in cui sembra che la chiesa stia di nuovo cedendo alla tentazione di tagliare i ponti con l’ebraismo. E qui ora arriviamo alla attualità.
La guerra che si è scatenata dal 7 ottobre del 2023 ha avuto tra le sue vittime il dialogo ebraico cristiano. Nel mondo si è sollevata un’ondata di ostilità antiisraeliana, in alcuni casi formalmente limitata alla critica del governo e del suo premier, ma poi allargata al popolo ebraico che si è stretto solidale con le sorti di Israele minacciato; le accuse contro Israele hanno rinfocolato e fatto leva su sentimenti antiebraici mai sopiti; il vocabolario usato è stato funzionale alla demonizzazione e al ribaltamento del senso di colpa per il genocidio, con parole e concetti propri di una tradizione di ostilità millenaria (crudeltà, vendetta, i bambini ecc.). Che c’entra in questo la Chiesa cattolica e il dialogo? È che la tragedia in corso non coinvolge solo Gaza, ma l’intera regione e comporta un rischio epocale per Israele, non compreso o sottovalutato; e questi concetti e vocaboli accusatori di Israele, anziché essere bilanciati in una visione obiettiva, sono stati ripresi da una parte della Chiesa, dalla base fino al vertice, che così ha fatto da cassa di risonanza e avallo morale della condanna. E perché non avrebbe dovuto farlo, ci si chiede?
Allarghiamo un momento la prospettiva su quanto succede nel mondo non tanto lontano da noi: Sudan meridionale, 400 mila morti; Yemen 400 mila; Siria almeno 400 mila; Tigrai (Etiopia) almeno 300 mila. 13 milioni di rifugiati e 24 milioni di profughi all’interno dei Paesi. Il numero di cristiani in medio oriente che cala vertiginosamente. Nel solo Iraq da 1.5 milioni a 250.000.
Questa lista incompleta degli orrori in corso coincide, se si considerano le posizioni dei vertici della Chiesa cattolica, con quella delle omissioni, delle distrazioni, del basso profilo, di citazioni generiche, che stride con l’attenzione sistematica e quasi quotidiana e con le parole di riprovazione e condanna nei confronti di Israele. Motivazione formale, la nobilissima compassione per i sofferenti e la condanna della crudeltà della guerra, che però quando è monotematica e unilaterale è sospetta. Si potrebbe obiettare che questo tipo di argomento, “c’è ben altro”, rientra nella deprecata categoria del cosiddetto “benaltrismo”, che serve a eludere o negare i fatti. In realtà, tutti i fatti (quelli veri, non quelli deformati della propaganda e riproposti acriticamente), sono da condannare, ma qua c’è veramente ben altro, e l’indignazione selettiva – per usare un’espressione oggi comune – perde la sua forza morale. A difesa del papa, Giuseppe Rusconi ha scritto che “un papa non può dividere il mondo in figli e figliastri e dunque deve denunciare le sofferenze di tutti”. Sono pienamente d’accordo. Ma è proprio quello che il papa non fa. Sappiamo che il papa ogni giorno è al telefono con il parroco di Gaza. Quante telefonate ha fatto in Sudan, Siria, Etiopia, Congo, Yemen e quante volte ne ha parlato? Non lo sappiamo. Però sappiamo che con l’appoggio mediatico della Chiesa, Israele, nel senso originario del popolo ebraico, e poi dello Stato che ha questo nome, è tornata sul banco degli imputati.
In tutto questo c’è da fare un’ulteriore riflessione. A proposito del conflitto israeliano palestinese, si è spesso parlato di sproporzione, riferendosi alla reazione israeliana. La vera sproporzione è un’altra; è, a confronto con altri eventi ben più tragici, l’attenzione mediatica concentrata su quei fatti, la propaganda avvelenata e menzognera che fa presa sulle persone. Perché c’è questa sproporzione? Perché c’è di mezzo Israele. In America, con amara ironia, usano un gioco di parole: No Jews no news, se non ci sono gli ebrei non c’è la notizia. E perché? Gli ebrei, malgrado siano una piccola minoranza dell’umanità, sono spesso al centro di avvenimenti di eccezionale gravità e di un’attenzione eccessiva. Tutto questo potrebbe avere una spiegazione politica e razionale. Ma a un pubblico che ha una sensibilità religiosa la spiegazione politica non deve bastare. Quello che stiamo vedendo in questi ultimi mesi è la ripetizione di uno schema antico e costante. Israele rappresenta per molti un nervo scoperto che basta stimolare per evocare reazioni eccessive. È un enigma, un problema irrisolto, una realtà con la quale è difficile convivere in pace, un ostacolo all’equilibrio delle persone e delle società. E non è un caso che questa difficoltà trovi espressione proprio nelle parole critiche del capo di milioni di fedeli. Per chi crede, e cerca nella religione ispirazione e sostegno, c’è qui qualcosa o molto di più della politica, della psicologia, della sociologia. È la condizione speciale di Israele nella storia e nella fede dell’umanità. Che il più delle volte porta l’umanità a esprimersi nei confronti di Israele nel peggiore dei modi possibili, come in questi giorni, ma che potrebbe e dovrebbe avere invece un’evoluzione virtuosa e positiva. È questa la sfida per chi ancora spera nel dialogo. Un dialogo da mesi rovinato, ma che non è e non deve essere, per chi crede, un evento banale da interrompere.
So che chi ha organizzato l’incontro di oggi, chi lo ospita, chi parla, chi ci ascolta è consapevole della necessità del dialogo e dell’amicizia e, per quello che può, si oppone alle derive politiche e teologiche che lo stanno minacciando. Vi ringrazio per la vostra attenzione e simpatia e mi auguro e vi auguro di non rimanere un’isola minoritaria.
Vorrei finire con una citazione da rav Sacks (To heal a fractured world, p. 166) che evoca il tema di oggi, la speranza: “Ottimismo e speranza non sono la stessa cosa… L’ottimismo è una virtù passiva, la speranza una virtù attiva. Non serve coraggio per essere ottimisti, ma ci vuole molto coraggio per sperare. La Bibbia ebraica non è un libro ottimista. È tuttavia una delle grandi letterature della speranza”.
La speranza è proprio il titolo di questo incontro, ed è questo il sentimento che dovremmo condividere, malgrado tutto.