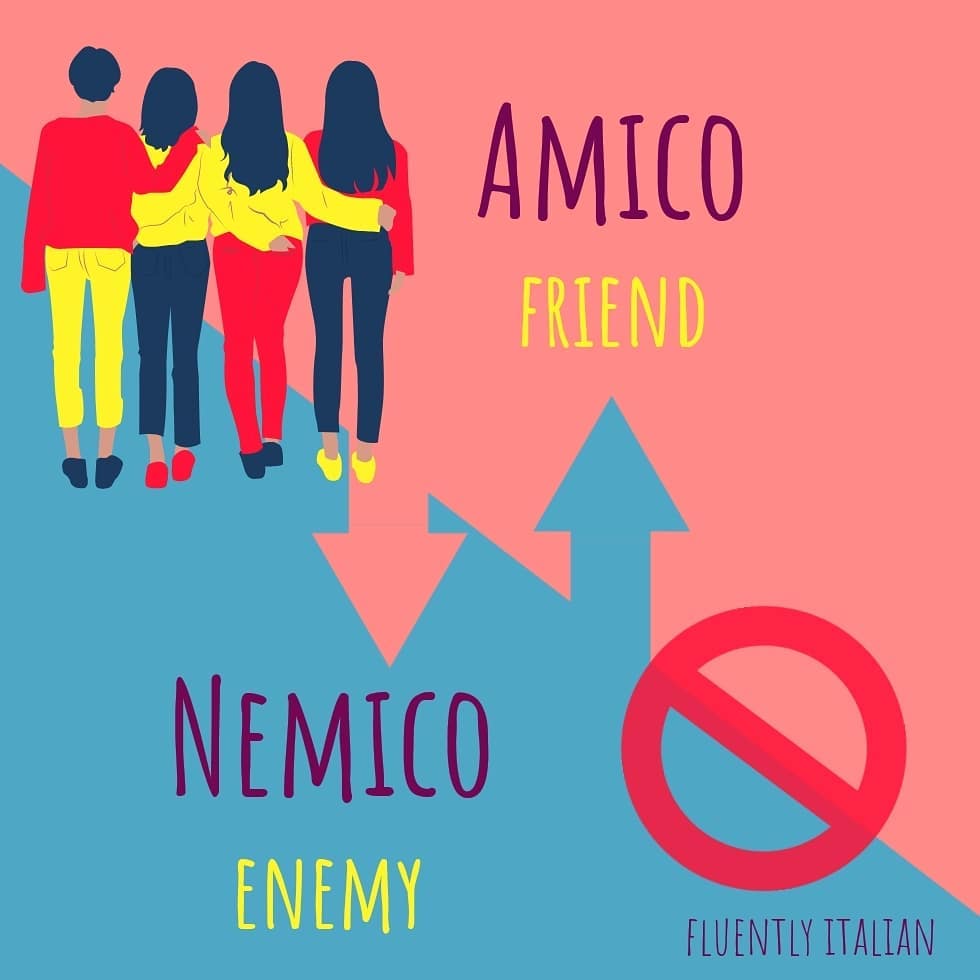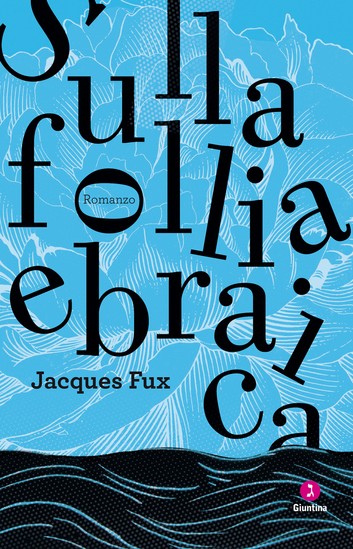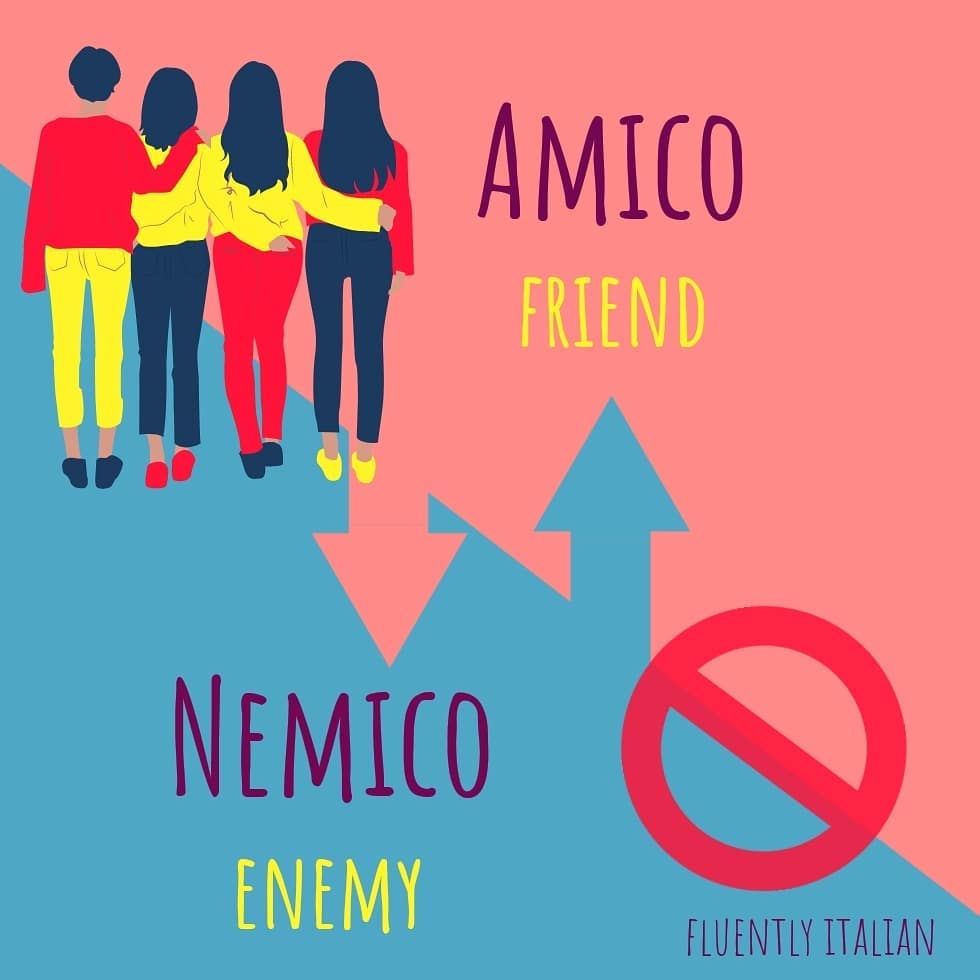
Sovente troviamo dei correligionari indignati perché scoprono che vi sono degli ebrei che votano a destra, i quali critici si dispiacciono non tanto perché sia sbagliato farlo – indubbiamente per qualcuno lo è – ma soprattutto perché lo fanno senza chiedere permesso ai tantissimi maîtres à penserche arricchiscono il panorama intellettuale italiano. Talvolta si ha la sensazione che ogni uomo di sinistra sia o aspiri ad essere un intellettuale, e perfino nei rarissimi casi in cui la sua prosa appaia costellata da sfondoni ed orrori grammaticali, è palese che tali lacune ubbidiscono al solo scopo di non mettere in imbarazzo il prossimo con la sua straordinaria cultura. Tuttavia, essere un intellettuale di sinistra (o di destra) costituisce una contraddizione in termini, perché tale definizione, in quanto delimita il perimetro delle conclusioni, rende superflua la ricerca.
All’interno del più vasto problema dell’amore e del suo contrario, in tesi, sarebbe normale aspettarsi che a livello istintivo si ami l’amico e si odi il nemico; poi intervengono la cultura e, in suo aiuto, la morale, per indirizzare verso migliori lidi tali reazioni primordiali. Per esempio, si potrebbe e si dovrebbe amare il nemico e, in quanto costui diventasse sempre più carogna, si potrebbe pure passare dall’amore all’adorazione, se non altro per dimostrarsi superiori.
Capita, però, per la legge dei grandi numeri, che l’uomo di destra possa dimostrarsi filosemita e quello di sinistra, antisemita. Il corollario dei ragionamenti fin qui menzionati è che il nemico debba essere amato e, fin qui, siamo nell’ambito della massima prevedibilità. Vi è, tuttavia, un non detto, il quale, ontologicamente, appare a stregua di una semplice e volgarissima conseguenza, che consiste nel dover odiare l’amico, in un atto di singolare masochismo. Certo, c’è amico e amico, ma ci sono anche quelli veri ed autentici, a prova di qualsivoglia critica e contradditorio.
Odiare il proprio amico – diciamolo – è un compito ingrato, ma per evitare le critiche, potrebbe diventare un sacrificio accettabile e, in fondo, d’una incoerenza non immorale. Rimanderei a Leon Festinger (A theory of cognitive dissonance, Stanford University Press, California, 1957, reprint 1968), il quale ebbe ad esaminare il rapporto fra credenze e nozioni: “it is certainly clear (…) that persons committed to a given behaviour end up rejecting information to which they are exposed which, if accepted, would produce dissonance with their cognition about their behaviour” (p. 156). Ad esempio, è noto il caso di un negazionista dal quale hanno preso le distanze, indignati, degli intellettuali palestinesi, fatto passare in Italia per un semplice critico della politica israeliana, con un meccanismo mentale che dovrebbe rimandare agli studi di Festinger.
Un famoso esperimento di Festinger riguardava un gruppo di ufologi che attendevano la fine del mondo e, quando nulla è successo, anziché ammettere di aver creduto ad una balla, sostennero di essere stati salvati dalla loro fede.
Harry Lime (Graham Greene, The Third Man, 1971, p. 104) per ridimensionare le sue colpe retrocede la natura degli uomini che vede dalla ruota panoramica di Vienna a semplici mosche. Un ulteriore esempio di scuola di dissonanza cognitiva riguarda la favola di Esopo nell’episodio della volpe e dell’uva.
Personalmente, m’imbatto spesso in ragazzi che vendono Lotta Comunista; quando gli si fa notare che la ‘ditta’ è fallita, rispondono che quello non era il vero comunismo.
Carlo Ginzburg, eccezionale storico ed accademico (Sorgente di Vita, 26 giugno 2016) asserisce che, per la madre, la straordinaria scrittrice Natalia (battezzatasi prima del secondo matrimonio), essere ebrea voleva dire “solidarietà con le vittime, solidarietà con (le vittime de) l’ingiustizia”. Potremmo arguire che, in quel senso, essere ebrei vorrebbe dire essere buoni per cui, se uno buono non fosse, non si comporterebbe da ebreo, perché essi, in tesi dovrebbero essere più buoni degli altri. D’altro canto, a leggere la biografia di Sandra Petrignani (La corsara – Ritratto di Natalia Ginzburg, Vicenza, 2018) il profilo che emerge è esattamente quello descritto dal figlio. In mezzo, la tempesta per il rifiuto di “Se questo è un uomo”, di Primo Levi (da attribuire a Pavese anziché alla Ginzburg, che all’epoca non aveva alcun potere decisionale, anche se costei, coraggiosamente, usò il plurale e non il singolare per descrivere la vicenda) che assurse alla dignità einaudiana molto più tardi e per la quale rimandiamo alla suddetta biografia. Sta di fatto che la (pur onesta e sincera) visione dell’ebraismo limitata alla solidarietà sembra più vicina al pensiero politico della bravissima Ginzburg che alla monumentale costruzione che è alla base della nostra fede.
Si potrebbe ipotizzare che questi atteggiamenti segnino un solco fra pensiero laico e fideismo, in quanto si assumesse che laico sia colui il cui pensiero sia basato su evidenze che, una volta superate da altre evidenze, comportino un mutamento delle proprie idee, mentre fideista sarebbe, invece, colui il quale si limitasse a cercare conferme dei propri atteggiamenti di fronte al mondo. Tuttavia, per addivenire a siffatte conclusioni, sarebbe bastato riprendere un passo da De Bello Gallico III,18, dove Giulio Cesare rileva che “homines id quod volunt credunt”, ossia, che è nella natura umana ritenere vero ciò che si desidera, un congegno mentale al quale nessuno di noi può sfuggire. Il problema, però, è che c’è sempre chi esagera.