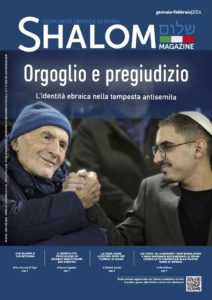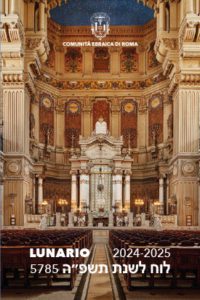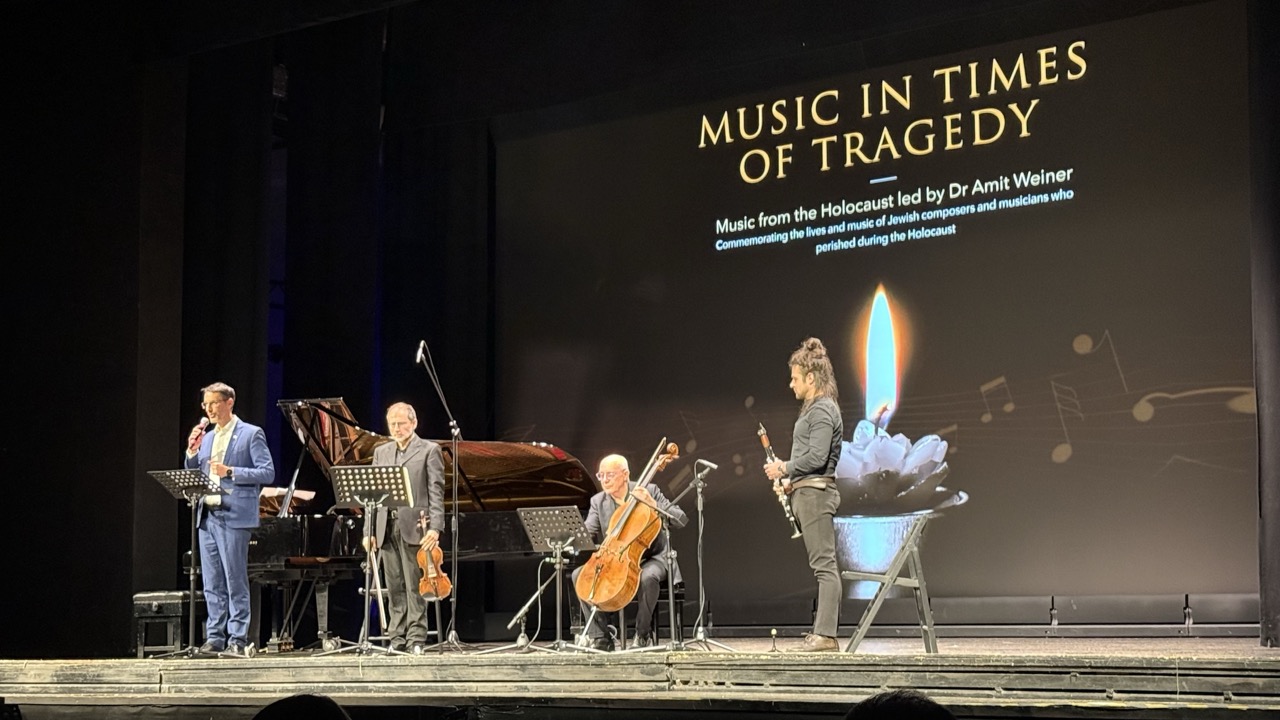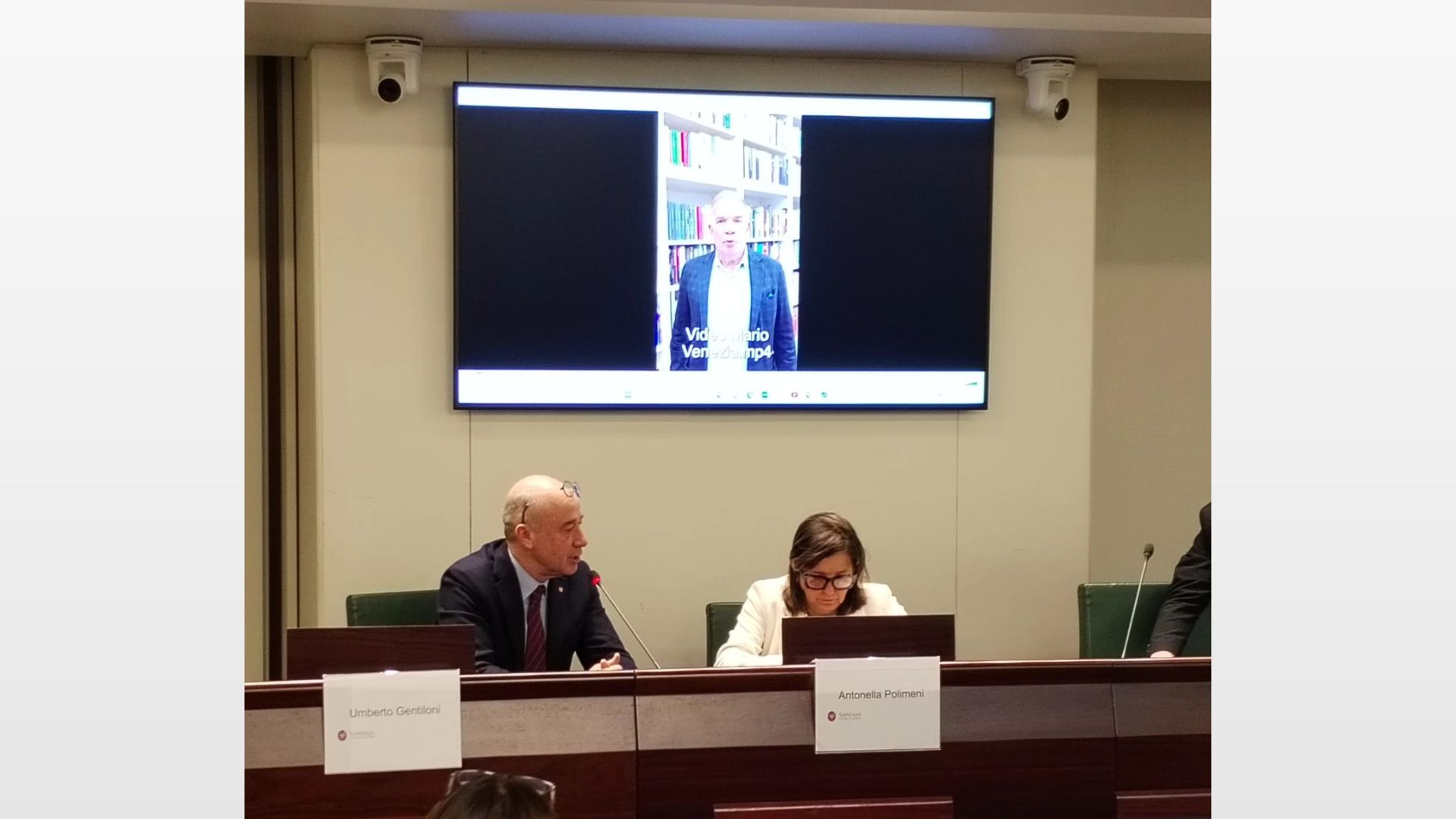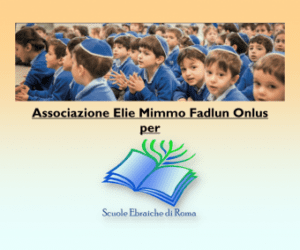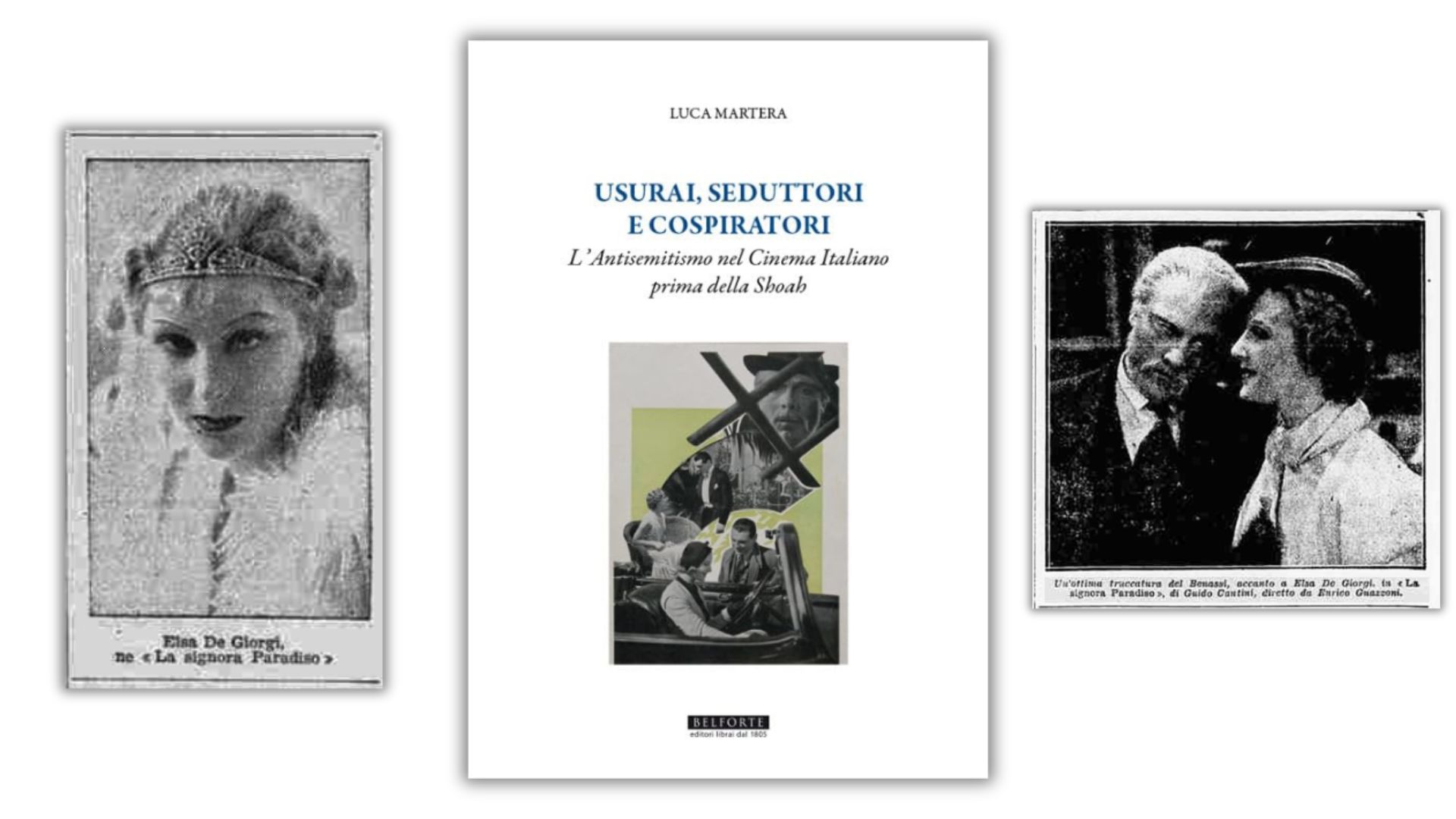
Nel 1934 uscì in Italia il film La Signora Paradiso di Enrico Guazzoni, tratto da una commedia di Guido Cantini. Apparentemente solo un drammone: un vecchio ricco e innamorato di una povera giovane, che trama per evitare l’amore di questa con un giovane attraente e senza mezzi – solo che il vecchio, protagonista del film, è il concentrato di tutti i possibili stereotipi antisemiti: è ebreo, di origine orientale; è robivecchi, ma anche banchiere; è avaro, subdolo e fa di tutto per controllare e rovinare le vite degli altri. È uno dei due più evidenti casi di cinematografia antisemita italiana raccontati da Luca Martera nel recente volume Usurai, seduttori e cospiratori. L’Antisemitismo nel Cinema Italiano prima della Shoah, pubblicato da Belforte, con il patrocinio della UCEI, l’Unione delle comunità ebraiche italiane.
Documentarista e ricercatore di storia audiovisiva, autore fra l’altro del libro Harlem. Il film più censurato di sempre (2021), Martera ha setacciato quasi mezzo secolo di produzione cinematografica italiana, ha sondato fonti archivistiche e documentarie, intervistato parenti dei protagonisti, giungendo alla conclusione che non è vero, come a lungo si è affermato, che in Italia, a differenza della Germania, non ci sia stata una produzione antisemita.
Durante il fascismo furono prodotti almeno due lungometraggi di argomento antiebraico. Dopo la La Signora Paradiso, nel pieno della guerra fu girato e montato il kolossal Piazza San Sepolcro di Giovacchino Forzano, che però non fu mai distribuito, travolto dagli eventi bellici e politici seguiti all’estate del 1943 e del quale non sembra esistere più nemmeno una copia. L’ambizione del film era raccontare un secolo e mezzo di storia come conseguenza di una trama ebraico-britannica per il dominio del mondo e dell’Europa, cui avrebbe messo fine la nascita del fascismo nel 1919, con la celebre adunanza di piazza San Sepolcro a Milano.
Oltre ai due lungometraggi, la minuziosa analisi di Martera (che parte dai primi film muti, dai kolossal biblici o pseudo-storici), indica che nel periodo tra il 1930 e il 1943 fu realizzata “una decina di film a soggetto con battute e personaggi secondari e una ventina di cinegiornali”, e che paragonando il minutaggio delle opere italiane con quelle tedesche prodotte tra il 1933 e il 1945 (si pensi, su tutte, a Süss l’ebreo e a I Rotschild), “i risultati più o meno si equivalgono”.
Lo studio è complicato dal fatto che a distanza di anni molti documenti non ci sono più e mancano le stesse pellicole. Ad esempio, il fatto che non si trovino oggi in archivio cinegiornali Luce esplicitamente destinati alla propaganda razzista, può essere il risultato di una consapevole scelta di opportunità o di una provvidenziale, successiva pulizia. Anche di La Signora Paradiso fino a poco fa non esisteva copia, un collezionista ne ha scovata una formato 16mm in Sud America, ma è monca di sette minuti, con evidenti e illogici tagli.
Martera inquadra le informazioni sui film nell’ambito più vasto della campagna antisemita del regime in campo culturale, della esclusione di cineasti e attori ebrei o dell’affidamento a loro di particine in anonimato, spesso proprio di personaggi ebrei dai tratti sgradevoli e stereotipati. Sono anche riprese puntualmente le polemiche antiebraiche nel cinema di personaggi come Giorgio Almirante, che sarebbe diventato nel dopoguerra leader del neofascista Movimento sociale italiano. Ma anche gli interventi di intellettuali che a quel clima collaborarono, diventando poi nel dopoguerra importanti esponenti della cinematografia democratica e di sinistra.
Naturalmente, non tutti i film che usano gli stereotipi antisemiti fanno parte della campagna esplicita del razzismo fascista. Il libro ha, tra gli altri, il merito di sottolineare come i pregiudizi e gli stereotipi antiebraici prevalenti nella cultura popolare (l’ebreo “deicida”, attaccato ai soldi, corruttore, fisicamente repellente, ecc.), informassero di sé ovviamente anche la produzione cinematografica. Anche La signora Paradiso, rispondeva – sottolinea l’autore – piuttosto a criteri di tipo “commerciale”, che politico. Il che, in realtà, rende il problema più serio e profondo, più difficile da identificare – anche in vista di un’auspicabile analisi del permanere di certe caratterizzazioni nelle produzioni del dopoguerra, che nel libro è appena accennata.