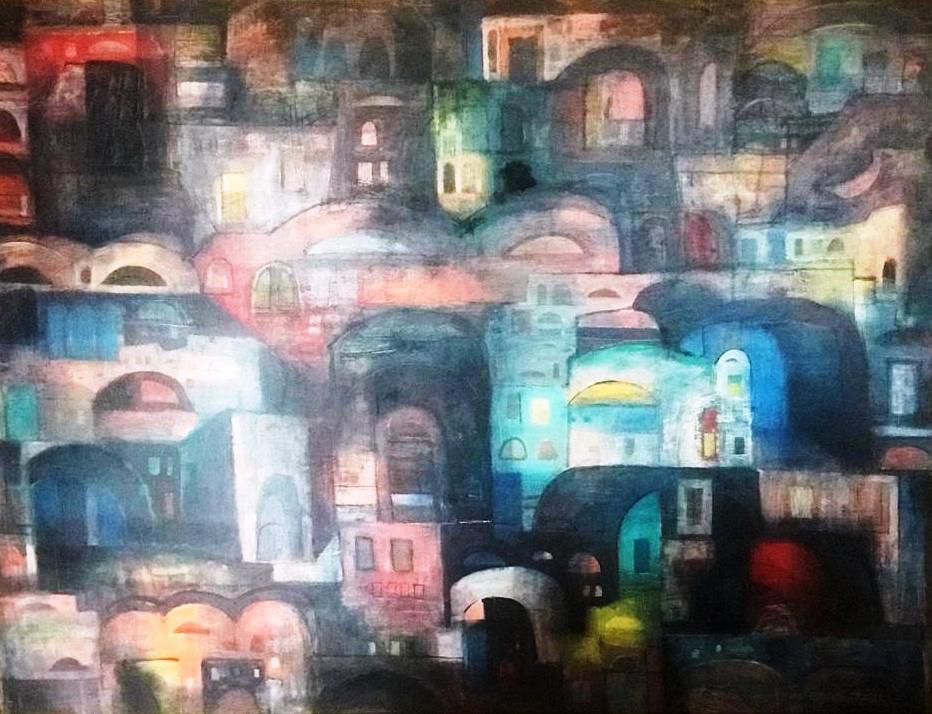
Nella
Roma del dopoguerra una pittrice attendeva a piazza Navona l’arrivo della luna
piena, per poter dipingere con la giusta luce la città dove aveva scelto di
vivere dal 1946. Quella giovane donna immobile e silenziosa era Eva Fischer che
sotto lo sguardo degli amici e dei passanti curiosi, che chiedevano
insistentemente cosa stesse facendo, affiggeva un cartello con su scritto «Si
aspetta la luna!». Un episodio semplice, di cui scrisse anche Oriana
Fallaci in un articolo del 1954, ma che racconta di una Roma sognante fatta di
incontri e di attesa per una ripartenza dopo anni difficili. Quel breve
messaggio da ora il titolo alla retrospettiva dedicata alla Fischer al Palazzo
di Città a Cagliari e che sarà visibile fino al 17 ottobre. La mostra a cura di
Alan Davìd Baumann ed Efisio Carbone ripercorre, con oltre 130 opere e
documenti, la carriera e la vita dell’artista scomparsa nel 2015 e di cui lo
scorso anno cadeva il centenario dalla nascita. L’ampia selezione di dipinti,
provenienti perlopiù dalla collezione della pittrice, va dagli anni ’40 ai
primi 2000 e si snoda in un percorso espositivo che occupa più livelli dello
storico palazzo del XIV secolo.
Quello
della Fischer è un lungo percorso umano e artistico cominciato a Daruvar una
città della ex Jugoslavia dove era nata nel 1920, figlia di Leopold un noto
talmudista e Rabbino Capo della città. Una vita fatta di spostamenti prima per
studio, diplomandosi all’Accademia di Belle Arti di Lione, per poi tornare a
Belgrado dai genitori e vivere il terrore dei bombardamenti del 1941.
Cominciavano così gli anni più dolorosi in cui i nazisti deportavano il padre e
decine di parenti, l’internamento con la madre e il fratello minore nel campo
di Vallegrande sotto l’amministrazione italiana e la vita a Bologna sotto falso
nome. La memoria della Shoah si manifesta nei volti graffiati nella materia
pittorica, in un ciclo di quadri realizzati nel segreto dello studio e mostrati
solo decine di anni dopo, il dolore per la perdita paterna in un dipinto come
il Taled di mio Padre del 1946 dove non c’è una presenza
fisica, ma viene rievocata la sua figura attraverso il manto da preghiera.
Poi c’è
Roma. La Fischer faceva parte di quella vita bohémien
che animava via Margutta e gli studi degli artisti come quello dello scultore
Amerigo Tot, dove si scambiavano idee e progetti, che accoglieva due volte a
settimana scrittori, registi, musicisti e i grandi personaggi di passaggio come
Dalì e Picasso. Conosceva poi le tante anime della città: dal
riscatto di Corrado Cagli, ritornato dall’esilio volontario in America
cominciato dopo le leggi razziali, al realismo politico di Renato Guttuso,
dall’impegno civile di Carlo Levi ai grandi maestri come Mario Mafai e Giorgio
de Chirico.
Nel
frattempo arrivavano i primi riconoscimenti con le mostre in Italia e
all’estero. La sua tecnica si era fatta più personale, sovrapponendo sulle tele
strati di colore che, una volta asciugati, le permettevano di grattare via
dalla superficie i pigmenti per far emergere temi ricorrenti come quello delle biciclette e
delle architetture dei Paesaggi mediterranei.
Nelle vetrate per il Museo Ebraico di
Roma, commissionate alla fine degli anni ’70, sono rappresentate le
architetture di Roma, Gerusalemme e delle antiche città d’Israele e i cui
bozzetti preparatori esposti in mostra non sono dissimili dalle vedute dei
paesini sardi realizzati dall’artista nei suoi soggiorni estivi. Una
testimonianza che crea un legame tra luoghi lontani, come propone Baumann che
racconta come questa mostra «costruisca un ponte ebraico attraverso il colore
che può unire l’antica comunità di Roma con Cagliari», città che ha visto una
presenza ebraica fino al 1492 e che ha riscoperto, in anni recenti, le sue
radici.















