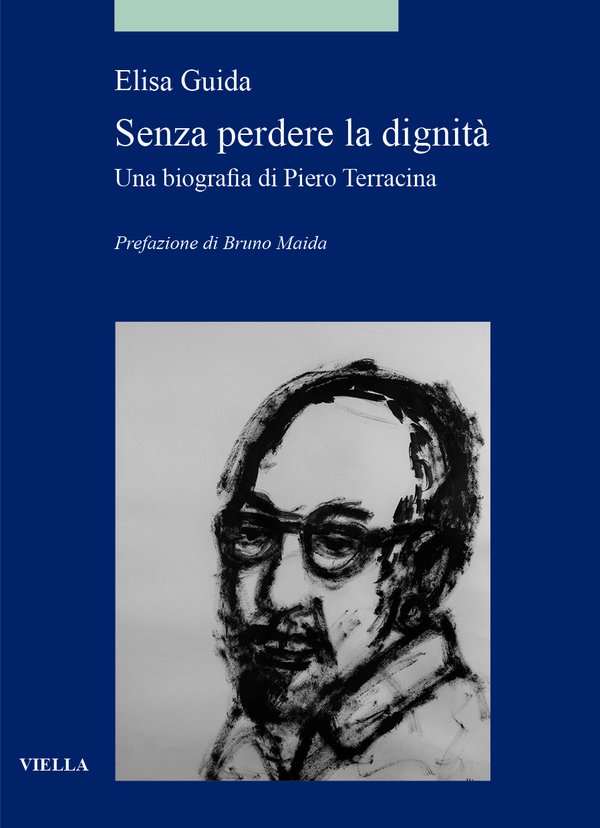“Il profumo di mio padre” è un inno all’amore filiale e alla memoria intima, privata. Dal connubio tra impegno civile e politico nasce un nuovo modo di fare memoria.
Il libro percorre a ritroso il vissuto dell’autore Emanuele Fiano in rapporto al padre Nedo, sopravvissuto ad Auschwitz di cui è stato attivo testimone. Un padre, come scrive Liliana Segre nella prefazione, non sempre facile, abitato dai suoi fantasmi e dai suoi incubi ma capace di lasciare al figlio una testimonianza di immenso valore.
Nedo non passava indifferentemente nella vita degli altri, fuggiva dalla polemica così come dall’attività politica, amava il pane nero, l’innovazione e il sapone Lifebuoy, a suo dire il profumo dei liberatori americani nel campo di Buchewald.
Sono gli anni ’50 e Nedo lascia con la moglie Rina il microcosmo fiorentino alla volta di Milano in cerca di prospettive migliori. Di questa città si ricordano vie e numeri civici, il trasloco verso un quartiere periferico e le estati afose trascorse sui libri in compagnia del suono monotono della lavapiatti.
E ancora i viaggi in macchina, le visite ai parenti ricchi in Toscana durante le pause natalizie e i panini ripieni di bresaola mangiati nell’area di sosta delle autogrill.
Il cibo, che assurge quasi a Leitmotiv del libro, sembra stonare con la fame del prima, del nazismo.
Nedo è autorevole, ripugna la carne al sangue, ha dei buchi sulle gambe e un alluce mozzato eppure nel libro non c’è traccia di vendetta, solo di rivalsa. Torna da Auschwitz spoglio, ma negli anni costruisce una famiglia, diventa manager e si laurea nel 1968 presso la Bocconi in Lingue e Letterature Moderne con una tesi sulla letteratura della deportazione degli ebrei dalla Francia.
Piangeva spesso, con le sue furie e i suoi dolori, ma pretendeva che i figli non facessero lo stesso.
Capitava durante il Seder di Pesach che gli venisse chiesto di leggere un passaggio che recita “noi fummo schiavi presso il faraone”; durante la liturgia ordinata Nedo cominciava piangere. Era stato anche lui schiavo pochi anni prima, non in Egitto ma in Germania. “Tutti noi siamo stati schiavi. Il valore della libertà può essere compreso solo da chi ne è stato privato”, diceva.
Questo racconto trascende la dimensione della Shoah e si rifugia nel terreno della responsabilità e della memoria in ogni sua declinazione.
Prendo in prestito le parole pronunciate da Liliana Segre durante la presentazione del libro avvenuta alcuni giorni fa: “Da madre vedo nella scrittura di Emanuele quello che mi auguro un giorno i miei figli scriveranno di me, spero che anche loro potranno dire di ricordare il profumo della madre». Aggiungo io: profumo che sa di libertà.