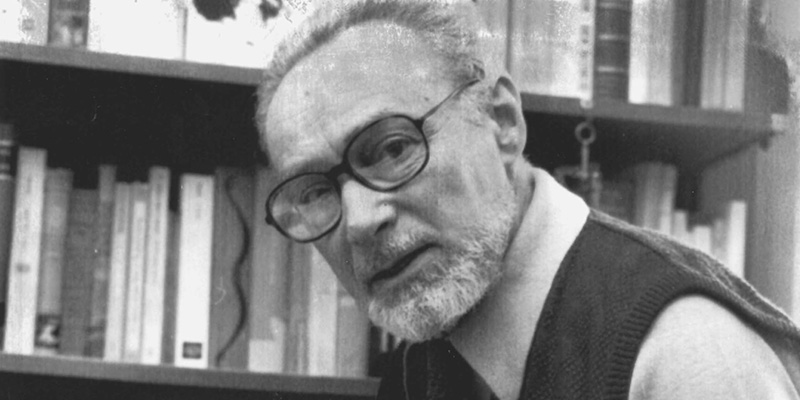
“Ci radono
i capelli, ci tatuano sul braccio un numero progressivo, ci denudano, ci
rivestono di stracci immondi a rigoni: non siamo più uomini. Nessuno spera più
di uscire”. C’è tutta la prosa di Primo Levi, la grandezza del narratore,
l’asciuttezza che ne sarà lo stile e nello stesso tempo la capacità di
accendere lo sdegno con la forza di un resoconto scientifico reso
drammaticamente eloquente dai numeri
(“Il 22 febbraio ’44 siamo partiti tutti, 650 disperati con bambini,
donne, vecchi, 50 rinchiusi in ogni vagone merci, 4 giorni, 4 notti di viaggio
senza dormire e senza bere.. siamo tornati
in 15”) nella lettera inedita che pubblica oggi il quotidiano La Stampa in
occasione dei 100 anni dalla nascita del grande scrittore torinese.
Resa
pubblica per concessione dei figli Lisa e Renzo, la lettera, due fogli battuti
fitti fitti a macchina con inchiostro rosso, riporta la data del 26 novembre
1945. Levi aveva solo 26 anni, era rientrato a Torino da meno di un mese ed era
già in cerca di un lavoro (“Sono ancora disoccupato, però ho imparato il
tedesco e un po’ di russo e di polacco, ed ho visto un bel pezzo di Europa che
pochi stranieri hanno visto”). Ai parenti lontani non nasconde niente, racconta
della decisione di salire in montagna con i partigiani per sfuggire alle leggi
razziali, l’arresto con le amiche Vanda e Luciana, il campo di Fossoli, la
deportazione, i suoi 11 mesi nel campo di Monowitz, satellite di Auschwitz, la
fame disperata, le condizioni impossibili, le selezioni, la morte. Un reportage
dall’inferno, lucidissimo e terribile, dove i sentimenti sembrano anestesizzati.
C’è il dramma incommensurabile e insieme un incredibile pudore, la totale
assenza di vittimismo, forse chissà già il tarlo dello sgomento per essere lui
tra i pochi che si sono salvati. “Quattro milioni di ebrei hanno varcato
la soglia della camera a gas. Per tre anni il camino ha oscurato il
cielo”, scrive ai parenti. Prima di lanciarsi in un’altrettanto lucida e
spietata analisi dell’Italia che ha ritrovato e anche dell’Europa (“Vecchia, maledetta e pazza”) con
parole che sembrano premonitrici e oggi più che mai attuali: “il fascismo
ha dimostrato di avere radici profonde, cambia nome e stile e metodi, ma non è
morto, e soprattutto sussiste acuta la rovina materiale e morale in cui esso ha
indotto il popolo”.















