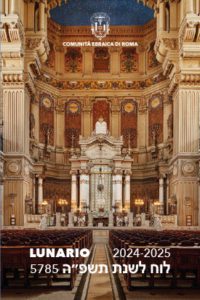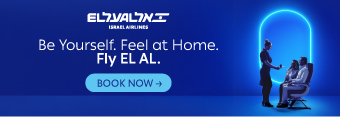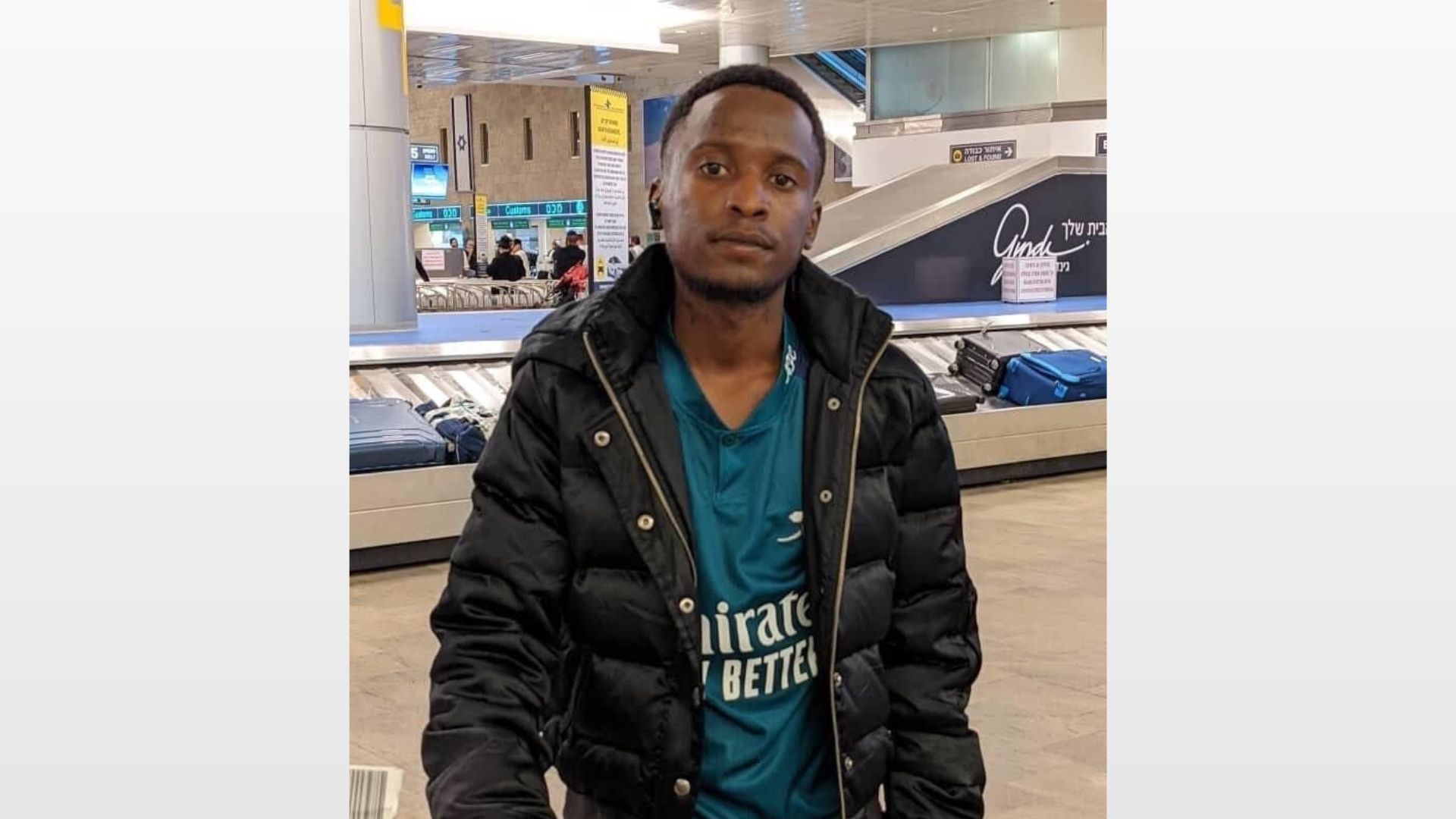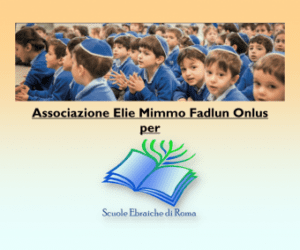Presso il Tempio Beth El si è tenuto l’incontro “L’esodo dimenticato: i pogrom libici del 1945 ottant’anni dopo”, un evento organizzato dal Centro di Cultura della Comunità Ebraica di Roma, volto a restituire voce all’antica comunità ebraica di Libia, una delle presenze più significative del Mediterraneo, e a una delle pagine più tristi della sua storia. L’incontro, moderato da Ariela Piattelli, direttore di Shalom, ha unito testimonianze dirette, immagini d’epoca e alcune proiezioni per ricordare una tragedia troppo spesso rimossa dalla memoria collettiva.
Tra i saluti iniziali, l’ambasciatore dello Stato di Israele a Roma, Jonathan Peled, e il rabbino capo di Roma, Rav Riccardo Di Segni,hanno sottolineato come la diaspora degli ebrei libici sia stata un capitolo molto scuro del passato, ma rappresentativo della forza del popolo ebraico di rinascere, sempre. “La nostra storia è fatta di persecuzioni e sopravvivenza – hanno ricordato. Mantenendo la fede, abbiamo potuto preservare la nostra identità anche nei momenti più difficili”.
Figlio e nipote di vittime del pogrom, Victor Fadlun, presidente della Comunità Ebraica di Roma, ha raccontato questa storia troppo dolorosa ma altrettanto necessaria. “Il pogrom del ’45 venne organizzato scientificamente: uomini massacrati, donne violentate, corpi ridotti in un unico abbraccio di cenere”. Per tre giorni, Tripoli si trasformò in un inferno. La furia omicida non trovò ostacoli, mentre nella hara, il quartiere ebraico, la resistenza fu disperata. Fadlun ha ricordato che all’epoca la Libia contava circa 110.000 abitanti, di cui il 25 % era di origine ebraica. Alla fine dei disordini, oltre 140 ebrei furono uccisi e centinaia di case e sinagoghe distrutte. Circa 600 persone furono costrette a lasciare la città. Durante i disordini, la Gran Bretagna, che al tempo amministrava il Paese, non intervenne e, ad oggi, ancora non ha mai chiesto scusa.
Dina Hassan ha letto un testo di Ariel Arbib che ricorda il paradosso stesso del rapporto con gli inglesi: furono loro a liberare gli ebrei libici dai campi di concentramento fascisti durante la Seconda guerra mondiale, ma pochi anni dopo restarono a guardare mentre si consumava il massacro.
In questo complesso quadro di sfondo storico, Claudio Procaccia, direttore del Dipartimento per i Beni e le Attività Culturali della CER, ha ricostruito le tracce di quella presenza ebraica plurimillenaria in Libia, già fiorente prima del periodo coloniale italiano. “Con l’ascesa di Muʿammar Gheddafi iniziò un esodo silenzioso che si inserisce nel clima di decolonizzazione e nel crescente nazionalismo arabo”. Nel 1967, durante la Guerra dei Sei Giorni, la convivenza tra ebrei ed arabi si spezzò definitivamente. Molti ebrei libici trovarono rifugio in Italia, dove la comunità romana li accolse, dando vita a un ebraismo rinnovato, arricchito da tradizioni diverse.
Dietro ogni voce si è riaffacciato un volto, un dolore di chi ha vissuto il pogrom. Tra questi, René Sasson ha ricordato la madre, uccisa in casa durante i disordini del 1945, mentre Tino Dabush ha raccontato i tentativi disperati della resistenza ebraica e la solidarietà di una vicina araba che gli salvò la vita. Infine, Elio Tesciuba ha descritto i primi anni della comunità ebraica a Roma e la nascita di nuovi templi, tra cui lo stesso Beth El. L’incontro si è concluso con il trailer del film di Hamos Guetta, dedicato alle famiglie ebraiche libiche e alla loro capacità di rinascere dal dolore: storie diverse, ma unite da una sola memoria.
I ricordi di quel pogrom riflettono quelle minacce e quei pregiudizi contro il popolo ebraico che non appartengono solo al passato. Ancora oggi, voci di odio e di antisemitismo risuonano nelle piazze, ma la consapevolezza e la forza maturate nel tempo ci rendono più uniti e vigili. L’esistenza dello Stato di Israele rappresenta oggi un punto di riferimento e di sicurezza per tutto il popolo ebraico e ricorda che, anche se una comunità può essere costretta a lasciare la propria terra, non potrà mai essere cancellata dalla storia.